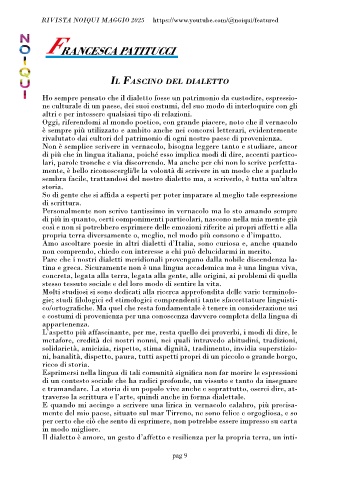Page 9 - RIVISTA GIUGNO 2025
P. 9
RIVISTA NOIQUI MAGGIO 2025 https://www.youtube.com/@noiqui/featured
F
RANCESCA PATITUCCI
Il FascIno del dIaletto
Ho sempre pensato che il dialetto fosse un patrimonio da custodire, espressio-
ne culturale di un paese, dei suoi costumi, del suo modo di interloquire con gli
altri e per intessere qualsiasi tipo di relazioni.
Oggi, riferendomi al mondo poetico, con grande piacere, noto che il vernacolo
è sempre più utilizzato e ambito anche nei concorsi letterari, evidentemente
rivalutato dai cultori del patrimonio di ogni nostro paese di provenienza.
Non è semplice scrivere in vernacolo, bisogna leggere tanto e studiare, ancor
di più che in lingua italiana, poiché esso implica modi di dire, accenti partico-
lari, parole tronche e via discorrendo. Ma anche per chi non lo scrive perfetta-
mente, è bello riconoscergli/le la volontà di scrivere in un modo che a parlarlo
sembra facile, trattandosi del nostro dialetto ma, a scriverlo, è tutta un’altra
storia.
So di gente che si affida a esperti per poter imparare al meglio tale espressione
di scrittura.
Personalmente non scrivo tantissimo in vernacolo ma lo sto amando sempre
di più in quanto, certi componimenti particolari, nascono nella mia mente già
così e non si potrebbero esprimere delle emozioni riferite ai propri affetti e alla
propria terra diversamente o, meglio, nel modo più consono e d’impatto.
Amo ascoltare poesie in altri dialetti d’Italia, sono curiosa e, anche quando
non comprendo, chiedo con interesse a chi può delucidarmi in merito.
Pare che i nostri dialetti meridionali provengano dalla nobile discendenza la-
tina e greca. Sicuramente non è una lingua accademica ma è una lingua viva,
concreta, legata alla terra, legata alla gente, alle origini, ai problemi di quella
stesso tessuto sociale e del loro modo di sentire la vita.
Molti studiosi si sono dedicati alla ricerca approfondita delle varie terminolo-
gie; studi filologici ed etimologici comprendenti tante sfaccettature linguisti-
co/ortografiche. Ma quel che resta fondamentale è tenere in considerazione usi
e costumi di provenienza per una conoscenza davvero completa della lingua di
appartenenza.
L’aspetto più affascinante, per me, resta quello dei proverbi, i modi di dire, le
metafore, eredità dei nostri nonni, nei quali intravedo abitudini, tradizioni,
solidarietà, amicizia, rispetto, stima dignità, tradimento, invidia superstizio-
ni, banalità, dispetto, paura, tutti aspetti propri di un piccolo o grande borgo,
ricco di storia.
Esprimersi nella lingua di tali comunità significa non far morire le espressioni
di un contesto sociale che ha radici profonde, un vissuto e tanto da insegnare
e tramandare. La storia di un popolo vive anche e soprattutto, oserei dire, at-
traverso la scrittura e l’arte, quindi anche in forma dialettale.
E quando mi accingo a scrivere una lirica in vernacolo calabro, più precisa-
mente del mio paese, situato sul mar Tirreno, ne sono felice e orgogliosa, e so
per certo che ciò che sento di esprimere, non potrebbe essere impresso su carta
in modo migliore.
Il dialetto è amore, un gesto d’affetto e resilienza per la propria terra, un inti-
pag 9