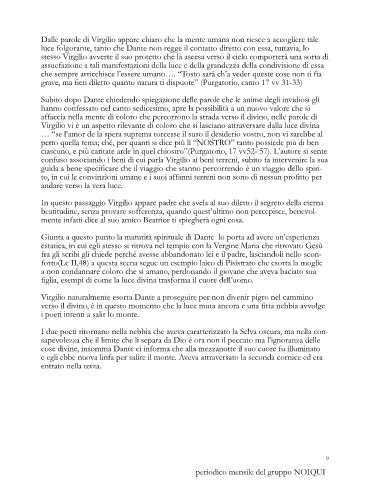Page 9 - RIVISTA NOIQUI NOVEMBRE 2021
P. 9
pIERA pIsTILLI
Dalle parole di Virgilio appare chiaro che la mente umana non riesce a accogliere tale
luce folgorante, tanto che Dante non regge il contatto diretto con essa, tuttavia, lo
LA VITA È TUTTA RICERCA DELLA LUCE stesso Virgilio avverte il suo protetto che la ascesa verso il cielo comporterà una sorta di
assuefazione a tali manifestazioni della luce e della grandezza della condivisione di essa
VIAGGIO NELLA COMMEDIA DEL LETTORE MODERNO che sempre arricchisce l’essere umano…. “Tosto sarà ch’a veder queste cose non ti fia
grave, ma fieti diletto quanto natura ti dispuote” (Purgatorio, canto 17 vv 31-33)
Per chiunque si avvicini all’opera dantesca è impossibile non notare l’importanza che Subito dopo Dante chiedendo spiegazione delle parole che le anime degli invidiosi gli
l’autore stesso concede alla luce, come elemento di vicinanza alle cose divine e quindi hanno confessato nel canto sedicesimo, apre la possibilità a un nuovo valore che si
segno di appartenenza e vicinanza allo stesso Dio. affaccia nella mente di coloro che percorrono la strada verso il divino, nelle parole di
L’Alighieri parte da una condizione di completa mancanza di luce, la selva oscura che Virgilio vi è un aspetto rilevante di coloro che si lasciano attraversare dalla luce divina
… “se l’amor de la spera suprema torcesse il suso il desiderio vostro, non vi sarebbe al
caratterizza il suo iniziale smarrimento innanzi alle tre belve, causa di ogni male umano petto quella tema; ché, per quanti si dice più lì “NOSTRO” tanto possiede più di ben
(la lonza, il leone la lupa). Sicuramente Dante non ha inventato nulla relativamente al ciascuno, e più caritate arde in quel chiostro”(Purgatorio, 17 vv52- 57). L’autore si sente
tema della luce che è presente in tutte le tradizioni religiose e filosofiche, inoltre Egli confuso associando i beni di cui parla Virgilio ai beni terreni, subito fa intervenire la sua
prende spunto anche dagli antichi poeti le sue immagini, ad esempio, proprio in riferi- guida a bene specificare che il viaggio che stanno percorrendo è un viaggio dello spiri-
mento alla lupa non possiamo dimenticare il verso: to, in cui le convinzioni umane e i suoi affanni terreni non sono di nessun profitto per
Eneide I, 323 andare verso la vera luce.
"E (Venere) per la prima: 'O giovani, disse, mostrate se forse In questo passaggio Virgilio appare padre che svela al suo diletto il segreto della eterna
vedeste qualcuna delle sorelle mie qui aggirarsi, beatitudine, senza provare sofferenza, quando quest’ultimo non percepisce, benevol-
faretra a tracolla, e d'una lince di pelle screziata mente infatti dice al suo amico Beatrice ti spiegherà ogni cosa.
o di bavoso cinghiale, ringhiando, inseguire la corsa."
Trad. Cesare Vivaldi Giunta a questo punto la maturità spirituale di Dante lo porta ad avere un’esperienza
estatica, in cui egli stesso si ritrova nel tempio con la Vergine Maria che ritrovato Gesù
Un verso tratto dal suo primo accompagnatore, dall’araldo inviato dalla luce per salvar- fra gli scribi gli chiede perché avesse abbandonato lei e il padre, lasciandoli nello scon-
lo dalle tenebre e condurlo alla luce. forto(Lc II,48) a questa scena segue un esempio laico di Pisistrato che esorta la moglie
La Luce caratterizza naturalmente i regni ove Dio è presente, per cui trova necessità a non condannare coloro che si amano, perdonando il giovane che aveva baciato sua
figlia, esempi di come la luce divina trasforma il cuore dell’uomo.
narrativa nel Purgatorio e nel Paradiso. Ed è proprio nel canto diciassettesimo del Pur-
gatorio che l’Alighieri esprime una verve poetica di ascesi verso la luce fisica che altro Virgilio naturalmente esorta Dante a proseguire per non divenir pigro nel cammino
non è che immagine della luce divina che custodisce il mondo e ogni creatura (“L’amo- verso il divino, è in questo momento che la luce muta ancora e una fitta nebbia avvolge
re che move il sole e tutte le altre stelle, canto 33 Paradiso, vv 145). i poeti intenti a salir lo monte.
Ma osserviamo con attenzione il canto del Purgatorio da noi accennato, con un’atten-
zione pedissequa Dante rivela che nel luogo dove si trovavano, mancavano tre ore al I due poeti ritornano nella nebbia che aveva caratterizzato la Selva oscura, ma nella con-
tramonto, per cui a Gerusalemme stava per iniziare il giorno essendo le tre del matti- sapevolezza che il limite che li separa da Dio è ora non il peccato ma l’ignoranza delle
no, Dante aggiunge “Da noi”, cioè in Italia era mezzanotte, il momento più buio della cose divine, insomma Dante ci informa che alla mezzanotte il suo cuore fu illuminato
notte; eppure, quello in cui colui che percorre il cammino spirituale entra nel nuovo e egli ebbe nuova linfa per salire il monte. Aveva attraversato la seconda cornice ed era
giorno, per cui il momento in cui può sperimentare una nuova consapevolezza. entrato nella terza.
Il momento successivo del canto è la teorizzazione in poesia del fenomeno della rifra-
zione della luce. Utilizzando una serie di accorgimenti poetici, Dante rende in linguag-
gio poetico le teorie di Euclide, Wilebo e dell’arabo Alhazen. Il suo sforzo letterario è
dettato dall’attenzione che egli vuol concedere alla diversità di luce che sta colpendo i
suoi occhi, non un semplice riflesso in una superfice che lo abbaglia ma una vera e pro-
pria fonte sovrannaturale; infatti, nei versi successivi l’autore incontrerà l’angelo della
Misericordia.
8 9
periodico mensile del gruppo NOIQUI periodico mensile del gruppo NOIQUI